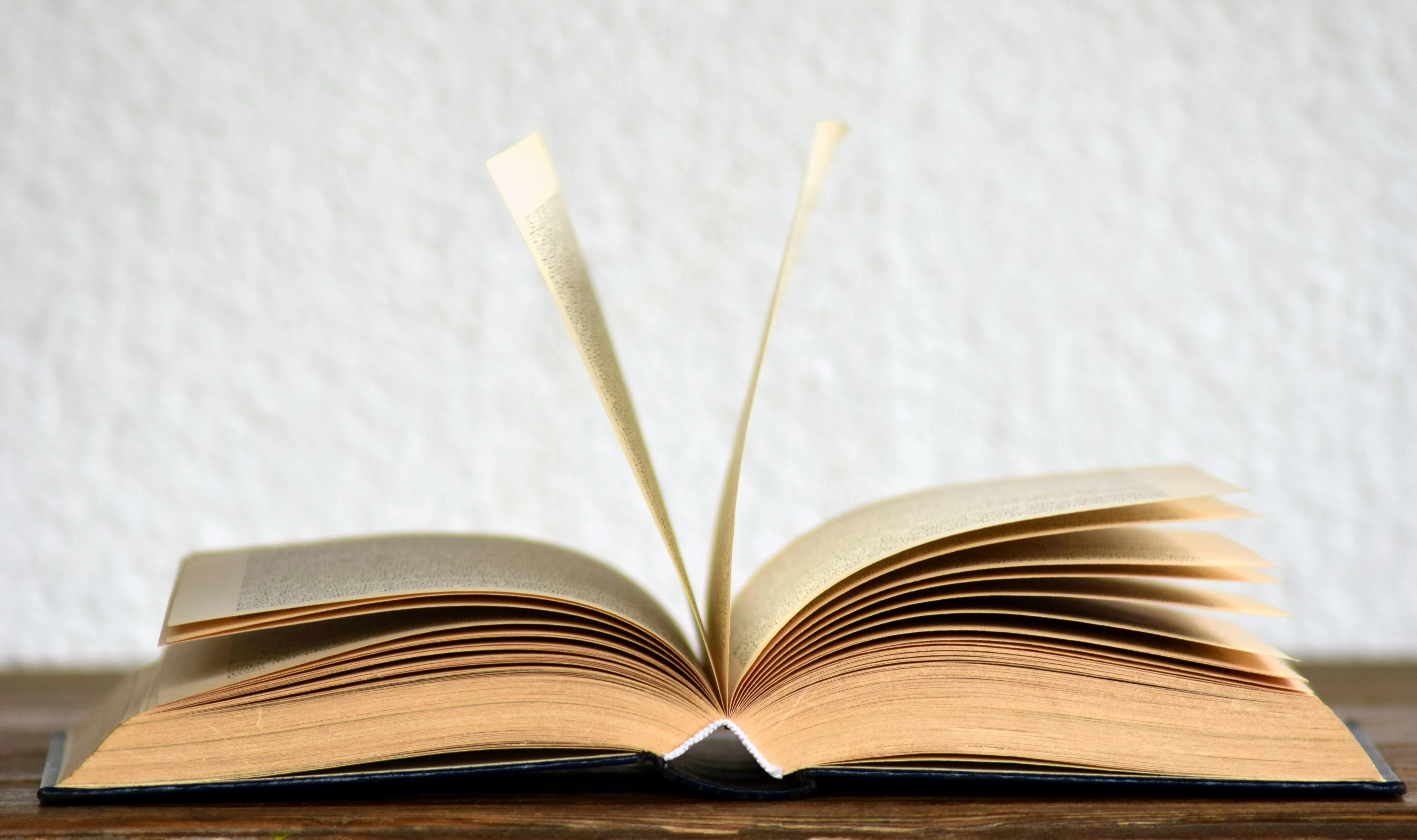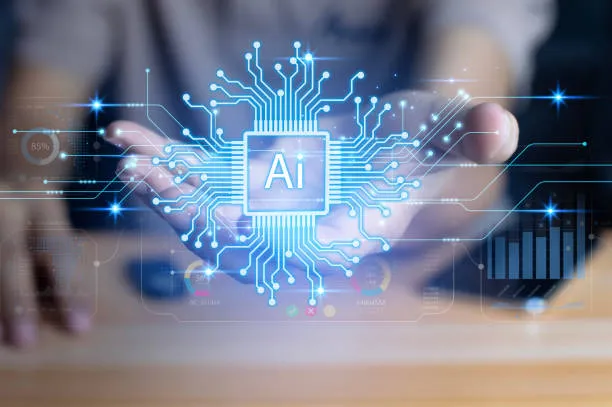Giambattista Vico, Chesterton e la barbarie che ritorna: rileggere il passato per comprendere il presente digitale
Indice dei contenuti
- Introduzione
- Vico e la filosofia della storia: una sintesi del suo pensiero
- Marcello Veneziani e il nuovo libro su Vico
- Vico tra Kant e la puntualità filosofica
- Vico, Chesterton e la diagnosi della barbarie moderna
- La distinzione tra barbarie interna ed esterna secondo Vico
- La cultura patriarcale in Vico
- Barbarie e modernità: il ritorno di un fenomeno antico
- I 'chierici armati di tablet': nuove élite e vecchi rischi
- Attualità del pensiero di Vico oggi
- Riflessione finale: Vico come bussola per il presente
Introduzione
In un’epoca in cui le trasformazioni tecnologiche ridefiniscono la nostra idea di cultura, educazione e comunicazione, tornare a riflettere sulla filosofia della storia di Giambattista Vico può apparire come un esercizio di archeologia intellettuale. Eppure, proprio oggi, le riflessioni del pensatore napoletano acquistano una straordinaria attualità. Lo dimostra il recente libro di Marcello Veneziani, che è tornato a puntare i riflettori sull’opera e sulla figura di Vico, affiancandolo a grandi nomi come Kant e Chesterton in una ricostruzione dettagliata della barbarie che sarebbe tornata a minacciare la nostra civiltà.
Questo articolo offre una panoramica esaustiva su come la filosofia di Vico e la sua diagnosi della barbarie siano tornate al centro del dibattito contemporaneo, in particolare attraverso il confronto con il pensiero di Chesterton e la narrazione che Veneziani offre nel suo libro.
Vico e la filosofia della storia: una sintesi del suo pensiero
Giambattista Vico (1668-1744) è oggi considerato uno dei più grandi filosofi della storia occidentale. Il suo contributo alla "filosofia della storia" consiste nell’idea che le società umane si sviluppano secondo cicli ricorrenti, segnati dall’alternarsi di età degli dei, degli eroi e degli uomini. L’umanità, nella visione di Vico, attraversa inevitabilmente fasi di progresso, apice e decadenza, fino a precipitare, di tanto in tanto, nella barbarie.
Vico pone al centro della sua riflessione il ruolo costruttivo della storia, la forza delle tradizioni e la necessità di interpretare i fatti storici attraverso la lente della ciclicità, contro ogni fede ingenua nel progresso lineare. La "barbarie" diventa per lui non una fatalità esterna, ma un fattore ricorrente e insidioso dentro la stessa civiltà.
Marcello Veneziani e il nuovo libro su Vico
Marcello Veneziani, noto saggista e filosofo italiano, si è impegnato recentemente in un’opera di riscoperta e rivalutazione di Vico. Nel suo nuovo libro dedicato a Giambattista Vico, Veneziani offre una lettura originale della figura del filosofo partenopeo, sottolineando quanto la sua analisi della crisi culturale sia attualissima nell'età digitale.
Il libro di Veneziani rappresenta un importante tentativo di riannodare i fili tra il pensiero settecentesco di Vico e i problemi della contemporaneità, in particolare per ciò che riguarda la riscoperta del senso di comunità, il recupero delle tradizioni e la comprensione delle nuove forme di "barbarie" che attraversano la società odierna. Attraverso questa opera, Veneziani invita lettori e studiosi ad assumere la prospettiva viquiana per scrutare i fenomeni contemporanei, in una chiara sfida all’attuale egemonia del pensiero tecnocratico e individualista.
Vico tra Kant e la puntualità filosofica
Un confronto spesso presente negli studi recenti – e ripreso anche da Veneziani – è quello tra Vico e Kant. Il primo, figlio della cultura italiana e napoletana, viene da alcuni considerato il "Kant italiano" proprio per la sua "puntualità" nel dare risposte teoriche ai grandi problemi della modernità.
Kant, filosofo dell’Illuminismo tedesco, propugnava l’autonomia della ragione e la ricerca di principi universali. Vico, invece, sostiene la specificità storica e culturale dei processi di conoscenza, mostrando come siano le comunità umane a costruire le proprie verità, non gli individui isolati. Pur tra profonde differenze, entrambi sono considerati monumenti della cultura europea, ma Vico mantiene una profonda radice nella cultura patriarcale e nella tradizione storica, che lo fa oggi risultare scomodo rispetto ai paradigmi più diffusi.
Vico, Chesterton e la diagnosi della barbarie moderna
G.K. Chesterton, grande scrittore britannico, colse forse meglio di ogni altro il valore profetico dell’opera di Vico. In alcuni suoi scritti, Chesterton sottolineava come il ciclo della civiltà, descritto da Vico, fosse simile al destino dell’Occidente: una società che, perduta la memoria delle proprie origini, rischia di precipitare nuovamente nella barbarie.
Oggi la "barbarie" non è più una minaccia remota o un flagello esterno, quanto piuttosto una dimensione internamente alla società, che ne devasta i valori, la razionalità e persino la capacità educativa. Chesterton e Vico, pur appartenendo a secoli e contesti diversi, ci lasciano in eredità una profonda diagnosi delle cause della decadenza: la perdita della dimensione comunitaria e della memoria storica.
La distinzione tra barbarie interna ed esterna secondo Vico
Un aspetto essenziale della riflessione di Vico è la distinzione tra barbarie interna ed esterna. La prima riguarda il degrado delle istituzioni, delle tradizioni e della cultura dall’interno della società, mentre la seconda si manifesta attraverso invasioni, crisi generate da fattori esterni o forze naturali.
Vico riteneva che la barbarie peggiore fosse quella interna, spesso inavvertita dagli stessi protagonisti: una società può prendere la strada inconsapevole dell’autodistruzione senza nemmeno rendersene conto, perdendo il senso della misura e della comunità. Oggi, nel turbine della rivoluzione digitale e mediatica, questa distinzione è più attuale che mai.
In punti, la distinzione verrà così articolata:
- Barbarie esterna: guerre, invasioni, calamità naturali, shock non previsti dal sistema.
- Barbarie interna: decadimento morale, smarrimento della memoria collettiva, cedimento delle istituzioni fondamentali (famiglia, scuola, comunità).
La "barbarie interna" rischia di rimanere silenziosa e invisibile, ma proprio per questo si dimostra devastante nella lunga durata.
La cultura patriarcale in Vico
Vico si fa anche interprete della cultura patriarcale tipica della sua epoca: la famiglia, il padre, la legge sono i cardini su cui si fonda la civiltà. Questo aspetto, spesso oggi criticato, è però letto da Veneziani non come un difetto, bensì come una caratteristica che ha permesso alla società tradizionale di resistere alle crisi e alle "barbarie" esterne e interne.
Il recupero di questi valori non è, per Veneziani, un invito nostalgico a tornare indietro, ma piuttosto una provocazione: nella società liquida, atomizzata e digitale, la mancanza di radici diventa uno dei principali vettori di decadenza. Per Vico, la storia non è mai solo progresso, ma sempre anche memoria, trasmissione di saperi e tradizioni che costituiscono il tessuto di una civiltà.
Barbarie e modernità: il ritorno di un fenomeno antico
La convinzione che la barbarie sia "ritornata", come sostiene Veneziani, poggia su una diagnosi acuta: mai come oggi i segni della crisi delle istituzioni educative, la perdita di senso e la violenza diffusa sono vividi nella società contemporanea. Ma, secondo la prospettiva viquiana, tale crisi non è affatto nuova: si tratta, piuttosto, del ritorno di fenomeni che ricorrono nei cicli storici dell’umanità.
L’incapacità di nominare la barbarie, cioè di identificarla e affrontarla direttamente, rappresenta uno dei sintomi più evidenti della crisi contemporanea. La sociologia della modernità ha spesso ignorato i segnali del degrado, ritenendo che la tecnologia o il progresso materiale potessero essere antidoti universali contro il ritorno della barbarie. Vico ammonisce invece sull’importanza di un’educazione al senso del limite, alla conservazione della memoria e delle tradizioni.
I 'chierici armati di tablet': nuove élite e vecchi rischi
Uno degli aspetti più provocatori del libro di Veneziani – e del dibattito odierno – è la figura dei "chierici armati di tablet". Si tratta della nuova élite intellettuale: non più, come nel passato, intellettuali e sacerdoti custodi della tradizione, ma tecnici e specialisti digitali che, invece di difendere la memoria civile, sperimentano incessantemente nuove forme di potere e di linguaggio.
Chi sono oggi i chierici armati di tablet?
- Giornalisti e opinion maker digitali
- Social media influencer e creator
- Docenti universitari orientati più all’innovazione tecnica che alla formazione umanistica
- Manager della comunicazione e della cultura digitale
Secondo Veneziani, l’egemonia di queste nuove figure genera una forma di barbarie non meno insidiosa di quella del passato: impoverisce il pensiero critico, favorisce la polarizzazione e riduce la profondità dello sguardo sulla realtà. Nelle scuole e nelle università, la didattica digitale rischia di sostituire l’educazione alla comprensione storica, mentre la memoria collettiva si dissolve nella fugacità dell’informazione immediata.
Attualità del pensiero di Vico oggi
Alla luce delle trasformazioni in atto, la filosofia della storia di Vico diventa uno strumento potente per analizzare il presente. Il ritorno della barbarie, la crisi delle istituzioni e lo smarrimento delle radici culturali costituiscono alcuni dei temi centrali sui quali il pensiero viquiano come quello chestertoniano si rivela ancora oggi prezioso.
Perché rileggere oggi Vico?
1.
Perché offre una teoria della storia alternativa al progressismo ingenuo.
2.
Perché invita a non dimenticare il ruolo della memoria e delle tradizioni.
3.
Perché propone una diagnosi lucida della crisi contemporanea, individuando nella "barbarie interna" il vero pericolo.
4.
Perché invita a una pedagogia della responsabilità e del limite, antidoti indispensabili alla deriva narcisistica dell’epoca digitale.
Tutte queste ragioni restituiscono centralità al pensiero di Vico, anche nei dibattiti attuali sulla scuola, la cultura e la crisi delle democrazie occidentali.
Riflessione finale: Vico come bussola per il presente
La lezione di Giambattista Vico, così come riletta oggi da Marcello Veneziani e intersecata dalle intuizioni di Chesterton, rappresenta una vera e propria bussola per orientarsi nel caos della modernità digitale. Nel tempo dei "chierici armati di tablet", il rischio non è solo quello di vedere la barbarie avanzare fuori dalle mura della città, ma di assistere al suo inesorabile infiltrarsi dentro il tessuto stesso della nostra cultura, educazione e società.
Rileggere Vico non significa rifugiarsi nel passato, ma recuperare gli strumenti necessari per affrontare le sfide del futuro: memoria storica, senso della misura, attenzione ai cicli e capacità di nominare i pericoli che minacciano la civiltà, anche quando appaiono sotto il volto rassicurante dell’innovazione tecnologica.
Alla luce di queste riflessioni, la barbarie interna descritta da Vico e la sua insidiosa attualità restano una provocazione essenziale per chiunque lavori nella scuola, nella cultura, nella politica e nella comunicazione oggi. Il pensiero viquiano ci invita a vigilare, a coltivare nuovamente le radici della civiltà e a contrastare la presunzione di autosufficienza dell’era digitale. Solo così si potrà evitare che la "barbarie" ritorni ancora una volta, travestita da progresso e innovazione.
Sintesi finale:
La filosofia della storia di Vico, riscoperta nella sua attualità da Marcello Veneziani, resta un punto di riferimento indispensabile per leggere le sfide contemporanee. La capacità di distinguere tra barbarie interna ed esterna, di riconoscere i limiti del progresso tecnologico e di riscoprire la memoria storica sono strumenti preziosi per affrontare l’incertezza del presente. Oggi più che mai, la voce di Vico – nella critica ai "chierici armati di tablet" e nella denuncia della crisi della civiltà – suona come un monito urgente e necessario nell’epoca della rivoluzione digitale.