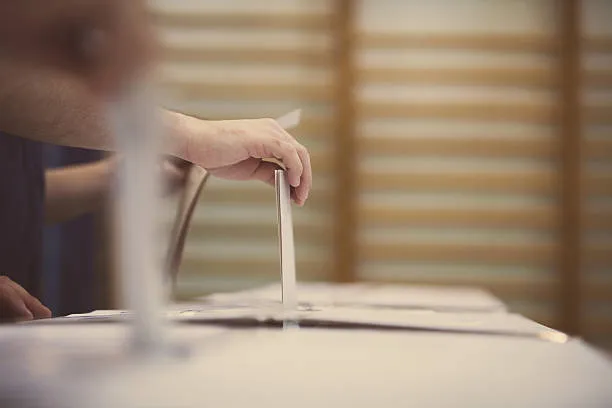Adolescenti e Disagio: Verso una Nuova Paternità Educativa. L'importanza della Presenza Adulta Oggi
Indice dei Paragrafi
- Introduzione: La questione degli adolescenti problematici
- "Adolescenti problematici" o adulti disorientati?
- La richiesta di relazione autentica da parte dei giovani
- Il caso della studentessa: ascolto o delega?
- Matteo Lancini e la prevenzione del disagio giovanile
- Nuove forme di paternità educativa
- Il ruolo della scuola e delle figure adulte
- Le famiglie di oggi: la sfida della separazione
- Adolescenti e psicologi: una soluzione sufficiente?
- Come aiutare realmente gli adolescenti
- Verso una nuova cultura educativa
- Sintesi e prospettive future
---
Introduzione: La questione degli adolescenti problematici
Nel dibattito pubblico odierno, la definizione di "adolescenti problematici" è spesso associata a comportamenti difficili, atteggiamenti chiusi, disagio interiore e a quella generale sensazione di inquietudine che contraddistingue sempre più i giovani di oggi. A tal punto che, nelle aule scolastiche e nei salotti familiari, non è raro sentire la domanda: "Cosa sta succedendo agli adolescenti?". La risposta, sostiene l’autore che interverrà oggi al Meeting di Rimini, non sta nel patologizzare i ragazzi, ma nel ripensare radicalmente la presenza adulta nella loro vita.
"Adolescenti problematici" o adulti disorientati?
È davvero corretto parlare di "adolescenti problematici" o sarebbe più onesto interrogarsi sul ruolo che gli adulti giocano nel fenomeno del disagio giovanile? Di fronte a una società che cambia troppo in fretta, spesso i genitori, gli insegnanti e gli educatori si trovano spiazzati, incapaci di leggere i segnali che i giovani inviano, affaticati dalla pressione di dover trovare risposte immediate a problemi complessi. Sempre più frequentemente, la tentazione è quella di etichettare gli adolescenti come "problematici"
Una domanda più autentica potrebbe essere: siamo noi adulti, con le nostre paure e la nostra incapacità di rischiare una relazione nuova, a generare parte del disagio che vediamo nei ragazzi?
Le parole chiave come relazione adulti adolescenti, prevenzione disagio adolescenti, paternità nuova adolescenza diventano oggi imprescindibili per affrontare la realtà senza pregiudizi.
La richiesta di relazione autentica da parte dei giovani
Dietro ai tanti comportamenti che definiamo "difficili" emerge spesso una richiesta silenziosa ma incessante di presenza. I ragazzi di oggi non cercano semplicemente "adulti che sappiano parlare", ma piuttosto uomini e donne disposti ad ascoltare e a mettersi in gioco, superando i cliché dell’autorità e della distanza emotiva. Gli adolescenti problematici chiedono adulti capaci di rischiare una paternità nuova, in grado di esporsi, di ammettere limiti e fragilità, di assumersi una responsabilità continuativa nel rapporto con loro.
Non bastano interventi tecnici o momentanei: ciò che i giovani domandano, spesso senza saperlo esprimere a parole, è una relazione significativa con chi li accompagna nel periodo più delicato della crescita.
Il caso della studentessa: ascolto o delega?
Una professoressa, intervenendo su questi temi, ha raccontato la storia di una sua studentessa. La ragazza, profondamente triste a causa della separazione dei genitori, non aveva trovato nell’ambiente scolastico qualcuno disposto ad ascoltarla realmente. La soluzione, troppo spesso praticata, è stata quella di indirizzarla direttamente a uno psicologo, senza soffermarsi sul valore di un ascolto umano e gratuito.
Questo episodio riflette una prassi ormai comune: la tendenza a delegare ai professionisti la gestione del disagio, scavalcando il ruolo insostituibile che la relazione diretta con l’adulto può avere per chi cresce. Il rischio è quello di considerare lo psicologo come il "depositario" esclusivo di una soluzione, dimenticando che la prevenzione del disagio passa prima di tutto da una presenza educativa capace di ascolto autentico.
I limiti della delega
- Riduce il problema a una questione "tecnica" o clinica
- Allontana la responsabilità degli adulti dal rapporto educativo
- Può far sentire il ragazzo "difettoso" anziché protagonista
Matteo Lancini e la prevenzione del disagio giovanile
Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta di respiro nazionale, ha più volte sottolineato come la vera prevenzione del disagio nelle nuove generazioni sia rappresentata, innanzitutto, dalla qualità delle relazioni che si instaurano tra ragazzi e adulti di riferimento. Secondo Lancini, non esistono adolescenti "a rischio" per natura, bensì giovani fragili perché privi di punti di riferimento solidi e di adulti capaci di rischiare una vicinanza empatica e non giudicante.
Lancini mette in guardia dalla facile soluzione di affidare troppo presto i giovani alle cure degli specialisti: senza una cornice affettiva e educativa forte, ogni percorso psicologico rischia di diventare un’ulteriore etichetta, un modo per "spostare il problema".
E gli insegnanti, come i genitori, diventano allora protagonisti indispensabili: non tanto per risolvere, ma per rimanere presenti, accompagnare, condividere dubbi e paure.
Nuove forme di paternità educativa
Nel linguaggio giornalistico e pedagogico si inserisce oggi il concetto di paternità nuova: non un semplice saper fare il padre (o la madre), ma accettare la sfida di essere adulti "coniugati nel rischio", capaci di assumere una funzione generativa sul piano esistenziale prima che su quello biologico.
Rispondere al disagio degli adolescenti problematici significa allora smettere di chiedersi solo "cosa non va nei ragazzi", ma interrogarsi profondamente su come si sta adulti nell’epoca dell’incertezza. Serve una paternità (e una maternità) che non si rifugi nel controllo, nella paura o nel giudizio, ma sappia essere permissiva quanto basta, calda e tollerante, presente e accogliente persino nell’imperfezione.
In questo quadro, la chiave della prevenzione disagio adolescenti diventa la prossimità: uno sguardo che accompagna, senza invadere, le scelte dei giovani nella loro progressiva autonomia.
Il ruolo della scuola e delle figure adulte
La scuola, oggi più che mai, è chiamata a fare la differenza. In un contesto sociale segnato dal disagio giovanile e da famiglie spesso in crisi, gli insegnanti assumono una funzione di "ponte" tra il mondo degli adulti e il bisogno di senso degli adolescenti. Accanto alle nozioni, diventa fondamentale:
- Incoraggiare il dialogo libero e sincero
- Offrire spazi di ascolto veri, non giudicanti
- Imparare a "stare nella fatica" dei ragazzi, senza pretendere soluzioni immediate
Essere adulti nell’educazione oggi significa anche accettare di non avere tutte le risposte, ma essere disponibili a camminare insieme
Le famiglie di oggi: la sfida della separazione
Uno dei fenomeni che maggiormente incidono sul benessere psicologico degli adolescenti è la diffusione delle famiglie separate. In queste realtà, i giovani sono spesso costretti a confrontarsi con sentimenti di abbandono, insicurezza, perdita di punti di riferimento solidi. Ma la separazione, di per sé, non determina necessariamente disagio: molto dipende dal modo in cui gli adulti gestiscono la situazione.
Quando genitori e insegnanti collaborano per mantenere una presenza educativa costante e coerente, anche nelle difficoltà, il rischio di disagio giovanile diminuisce nettamente. Serve uno sforzo di "crescita parallela", che coinvolge l’intera comunità educativa.
Alcuni suggerimenti per genitori separati:
- Evitare di mettere i figli al centro dei conflitti
- Mantenere costanti i momenti di ascolto e dialogo
- Condividere regole e valori educativi tra genitori, pur nella diversità degli stili di vita
Adolescenti e psicologi: una soluzione sufficiente?
Affidare subito un adolescente a uno psicologo – come avvenuto nel caso della studentessa triste – rappresenta un gesto di cura, ma non può essere l’unica risposta. Spesso serve, prima ancora della terapia, la possibilità di vivere ambienti in cui il dialogo e l’accoglienza siano la regola. Troppo spesso, invece, la prassi scolastica o familiare preferisce delegare la gestione del malessere a figure specialistiche, smarrendo la dimensione educativa della relazione.
Gli psicologi giocano un ruolo prezioso, specie nei casi più complessi, ma non possono sostituire il rapporto educativo diretto che si costruisce giorno dopo giorno con i ragazzi. Il rischio è quello di "medicalizzare" il disagio, anziché affrontarlo come parte fisiologica di una crescita fatta anche di fatica, crisi, errori e conflitti.
Come aiutare realmente gli adolescenti
Se la prevenzione disagio adolescenti si gioca nella qualità delle relazioni, allora occorre rimettere al centro alcune strategie fondamentali. Ecco un vademecum per genitori, insegnanti e adulti che hanno a cuore il futuro degli adolescenti:
- Ascoltare senza giudicare: creare spazi dove i ragazzi possano parlare di sé, delle loro paure e fallimenti, senza il timore di "deludere".
- Favorire la responsabilizzazione: aiutare i giovani a sentirsi protagonisti della loro vita, assegnando fiducia e lasciando margini di scelta.
- Dare l’esempio di adultità: mostrare che crescere comporta fatica, tentativi e cadute; raccontare le proprie esperienze può aiutare i ragazzi a sentirsi meno soli.
- Accogliere la fragilità: non considerare l’errore come un fallimento, ma come parte integrante del percorso adolescenziale.
- Collaborare tra adulti: creare reti di sostegno tra famiglie, scuola, servizi, parrocchie e associazioni, per non lasciare le famiglie isolate.
Verso una nuova cultura educativa
Il vero antidoto al disagio non è un modello educativo "perfetto" ma una comunità adulta capace di prendersi in carico la complessità delle nuove generazioni. Serve un coraggio educativo nuovo: la disponibilità ad accompagnare senza la pretesa del controllo totale, l’onestà nel riconoscere i propri limiti, la disponibilità al dialogo anche su temi difficili.
Prima di tutto, occorre interrompere la catena della delega e della sfiducia: i ragazzi hanno bisogno di vedere che gli adulti credono nel loro futuro, anche quando loro stessi sembrano non crederci.
Sintesi e prospettive future
In conclusione, definire gli adolescenti problematici solo in termini di disagio, crisi o sintomo, rischia di semplificare una questione ben più profonda. Dietro alla sofferenza si celano domande vere, che chiamano gli adulti a una responsabilità nuova: rischiare una presenza educativa autentica, prendersi cura della relazione senza aver paura della fatica, costruire giorno per giorno una paternità nuova che non è controllo, ma affidamento.
Come sarà l’adolescenza di domani? Dipende soprattutto dagli adulti di oggi, dalla loro capacità di riscoprire la loro funzione educativa e di camminare con i più giovani anche nelle ombre. Al Meeting di Rimini, e non solo, si apre così un dibattito fondamentale per il futuro della società: quello su come aiutare gli adolescenti a essere protagonisti della propria crescita, e non semplici destinatari di risposte precostituite.
In questa sfida, occorre coraggio. Ma anche la fiducia che, nella relazione tra generazioni, sia sempre possibile prevenire il disagio e contribuire a una società più giusta, accogliente e umana.