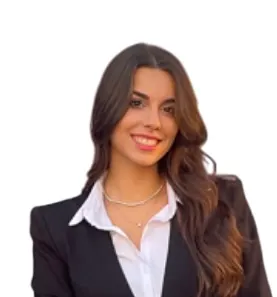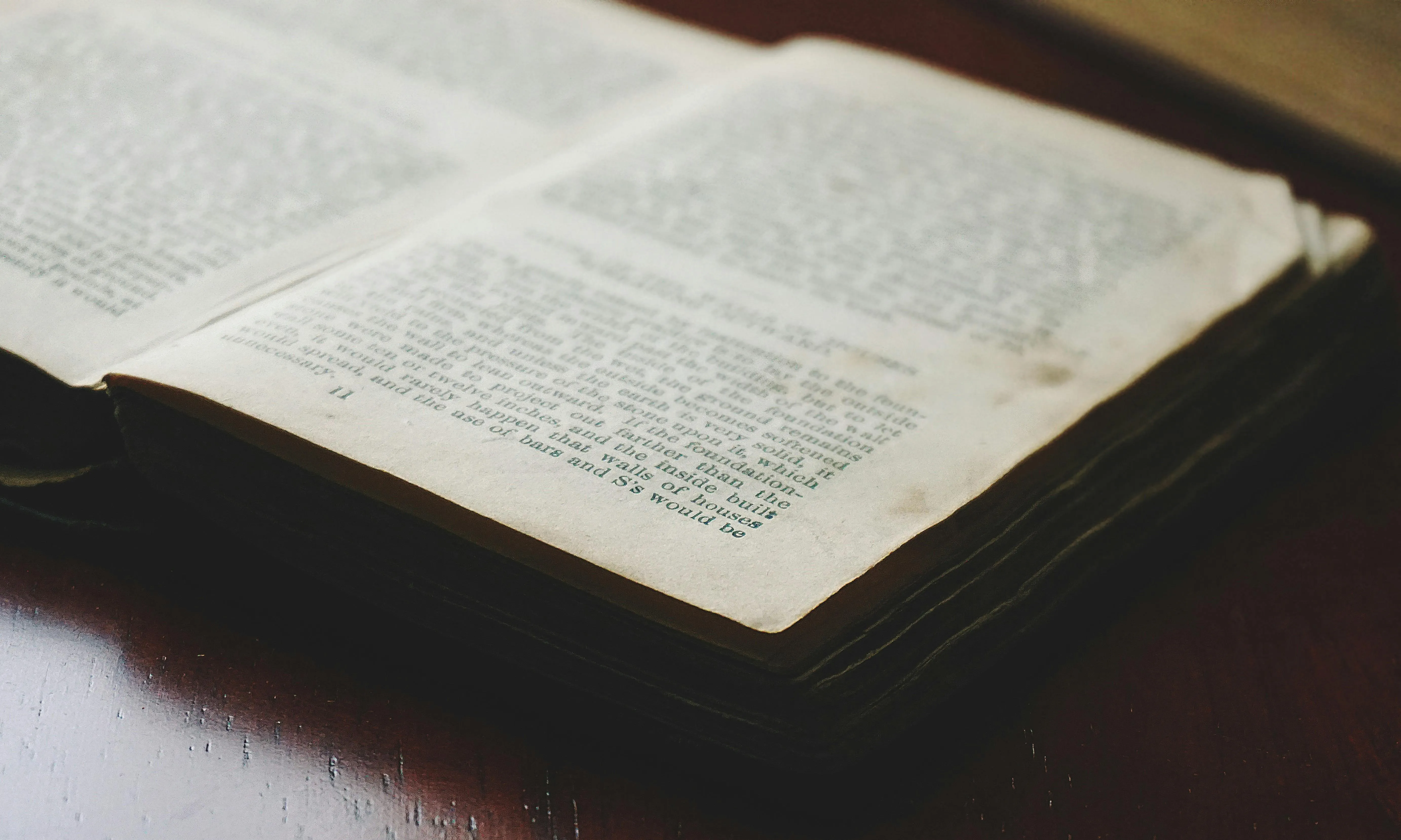Origini e obiettivi dell'iniziativa culturale
La Capitale Italiana della Cultura rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci messi in campo dal Ministero della Cultura per valorizzare in modo sistematico il patrimonio storico, artistico e identitario delle città italiane. Istituito nel 2014, il titolo nasce con l’obiettivo di trasformare la cultura in un vero motore di sviluppo: non un semplice contenitore di eventi, ma un progetto di ampio respiro capace di attivare processi di rigenerazione urbana, crescita economica, innovazione sociale e partecipazione dal basso.
Ogni città selezionata riceve un finanziamento di un milione di euro, utile a costruire un programma annuale di iniziative che puntano ad aumentare la visibilità nazionale e internazionale dei territori coinvolti. Questo impegno assume un ruolo ancora più significativo in un Paese come l’Italia, dove la cultura rappresenta un asset strategico storicamente riconosciuto, ma non sempre adeguatamente sostenuto o valorizzato.
Le città in corsa per il 2028: identità e progetti
In questo contesto, il percorso verso la Capitale Italiana della Cultura 2028 ha raccolto un interesse straordinario, quasi 25 Città e Unioni di Comuni hanno presentato un dossier di candidatura, dimostrando quanto il titolo sia ormai percepito come un’opportunità concreta per rafforzare il tessuto culturale e rilanciare l’economia locale.
Le proposte sono estremamente diverse tra loro: si va da città di grandi dimensioni come Catania, che con il progetto “Catania continua” punta a un rilancio identitario fondato sulla continuità culturale, a realtà storiche come Benevento o Anagni, fino a territori più piccoli ma sempre più attivi nella promozione culturale, come Pieve di Soligo, Valeggio sul Mincio, Mirabella Eclano o l’Unione dei Comuni Città Caudina.
Molti progetti si concentrano su temi attuali come innovazione sociale, tutela dell’ambiente, tradizioni locali, coesione comunitaria e dialogo intergenerazionale. Questa varietà di visioni dimostra come la cultura, quando sostenuta da una strategia chiara, possa diventare un catalizzatore di cambiamento reale, in grado di coinvolgere istituzioni, cittadini, associazioni e imprese. Le proposte rappresentano visioni strategiche che puntano a promuovere la cultura come leva di partecipazione civica, sviluppo e innovazione. Le città attualmente in gara sono :
- Anagni (FR)- “Hernica Saxa. Dove la storia lega, la cultura unisce”;
- Ancona – “Ancona. Questo adesso”;
- Bacoli (NA) – “Il futuro parte da una scossa”;
- Benevento – “Attraversare l’invisibile”;
- Catania – “Catania continua”;
- Colle di Val d’Elsa (SI) – “Colle28. Per tutti, dappertutto”;
- Fiesole (FI) – “Dialoghi tra terra e cielo”;
- Forlì – “I sentieri della bellezza”;
- Galatina (LE) – “Il sogno dei luoghi”;
- Gioia Tauro (RC)- “La cultura è Gioia”;
- Gravina in Puglia (BA)- “Radici al futuro”;
- Massa – “La Luna, la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia”;
- Mirabella Eclano (AV) – “L’Appia dei popoli”;
- Moncalieri (TO)- “La periferia fa centro”;
- Pieve di Soligo (TV) – “Io Siamo”;
- Pomezia (RM) – “Dal mito di Enea alle città di fondazione”;
- Rozzano (MI) – “La cultura oltre i luoghi comuni”;
- Sala Consilina (SA) – “Un ponte tra storia e futuro”;
- Sarzana (SP)- “L’impavida. Crocevia del futuro”;
- Tarquinia (VT) – “La cultura è volo”;
- Unione dei Comuni della Città Caudina – “Terra futura. Europa abita qui”;
- Valeggio sul Mincio (VR) – “Coltiviamo le persone”;
- Vieste (FG) – “L’anima bianca della Puglia”;
Criteri di selezione e valore aggiunto
Il processo di selezione è lungo, rigoroso e strutturato in più fasi, proprio per garantire la qualità e la sostenibilità delle proposte. Dopo la presentazione dei dossier, una giuria composta da sette esperti del mondo della cultura, dell’arte contemporanea, del turismo e della valorizzazione territoriale procede alla valutazione preliminare, che porta alla scelta di dieci finaliste.
A quel punto si entra nella fase delle audizioni pubbliche, un momento fondamentale in cui i rappresentanti delle città hanno l’opportunità di illustrare il proprio progetto in modo approfondito, evidenziando non solo la visione culturale ma anche la capacità di trasformare il territorio e di coinvolgere attivamente la comunità locale.
I criteri di valutazione includono innovazione, fattibilità economica, sostenibilità organizzativa, capacità di attrazione turistica e, soprattutto, l’impatto potenziale sul benessere dei cittadini. Più che un semplice concorso, si tratta quindi di un vero percorso di progettazione strategica che porta le città a ripensare sé stesse in chiave culturale, anche qualora non ottengano il titolo.
Agrigento, l’Aquila e Pordenone: le città in carica
In questo momento la Capitale Italiana della Cultura in carica Agrigento, sta portando avanti il suo programma annuale con il progetto “Il sé, l’altro e la natura. Relazioni e trasformazioni culturali”, mentre lo sguardo nazionale è già rivolto alle prossime città designate.
Per il 2026, il titolo è stato attribuito a L’Aquila, con il progetto “L’Aquila Città Multiverso”, un ambizioso percorso che pone al centro multiculturalità, multidisciplinarietà, multitemporalità e altre chiavi di lettura destinate a raccontare la complessità del territorio e la sua volontà di rigenerarsi dopo gli anni difficili seguiti al sisma.
Per il 2027, invece, la scelta è ricaduta su Pordenone, che ha convinto la giuria con “Pordenone 2027. Città che sorprende”, un progetto che mette in dialogo patrimonio storico, arti visive, cinema, partecipazione cittadina e nuove forme di narrazione urbana. Queste designazioni dimostrano come il titolo continui a evolversi, includendo sia realtà che puntano alla rinascita culturale sia città che vogliono consolidare il proprio ruolo nel panorama culturale nazionale.
Impatto sul territorio e sulla comunità
I benefici per le città che ottengono il titolo sono numerosi e, soprattutto, duraturi. Oltre all’immediato aumento della visibilità mediatica e turistica, la Capitale Italiana della Cultura rappresenta un’opportunità per accelerare investimenti pubblici e privati, valorizzare spazi urbani spesso dimenticati, consolidare reti culturali già esistenti e crearne di nuove.
Non meno importante è il potenziamento del senso di appartenenza della comunità: la partecipazione attiva dei cittadini, delle scuole, delle associazioni e delle imprese locali contribuisce a costruire un’eredità che va oltre l’anno della candidatura, lasciando in dote nuove competenze, una maggiore consapevolezza del patrimonio locale e un sistema culturale più forte e strutturato.
Per il bando 2028, le dieci finaliste verranno annunciate entro marzo del 2026, permettendo così un adeguato periodo di preparazione e confronto pubblico; successivamente, la vincitrice sarà proclamata entro la fine dello stesso mese, con un percorso che consentirà alla città selezionata di pianificare a lungo termine il proprio anno di celebrazione. In questo modo, il titolo continua non solo a dare impulso immediato, ma anche a favorire una progettualità stabile e un’impronta culturale che può farsi memoria e futuro.