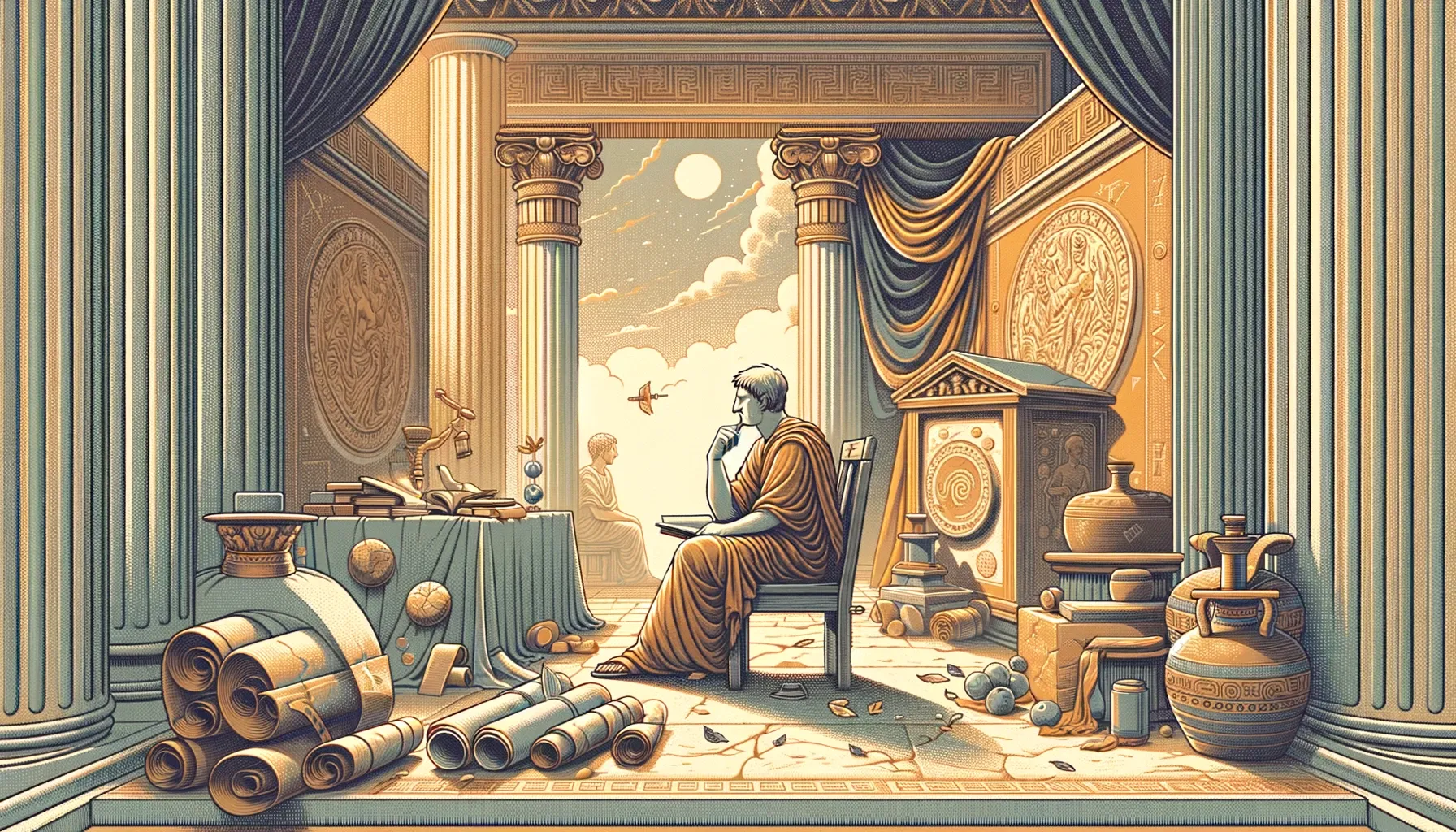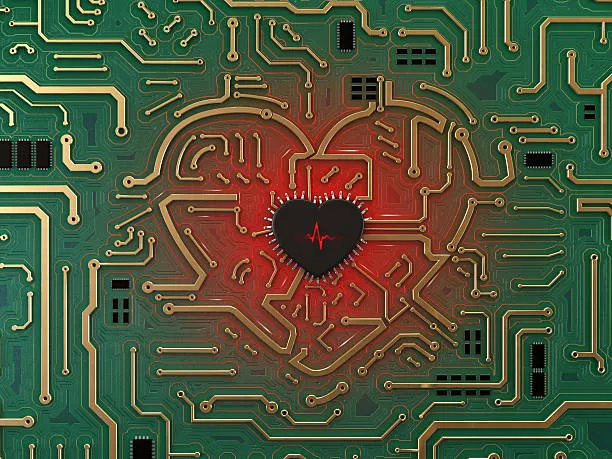Seneca e la nuova scuola: tra divieto di smartphone, orientamento e generazioni anfibie
Indice
- Introduzione
- Il divieto di dispositivi elettronici nelle scuole superiori: contesto e implicazioni
- Il caso di Verona: un laboratorio di ascolto e confronto
- Generazione Z e Alpha: la sfida dell’educazione “anfibia”
- Relazioni online e in presenza: costruire nuovi equilibri a scuola
- Dalla PCTO alla 'Formazione scuola-lavoro': un cambiamento non solo semantico
- L’urgenza di un nuovo orientamento: lotta alla fobia scolare e alle nevrosi
- Seneca in cattedra: la lezione ancora attuale per psicologi, studenti e docenti
- Conclusioni: una scuola più umana per il 2025
Introduzione
All’inizio di ogni anno scolastico, il mondo della scuola si interroga su come rinnovarsi alla luce delle sfide poste dalla società e dalla tecnologia. Il 2025 si apre con un ventaglio di novità che disegnano nuovi scenari educativi per studenti, docenti e famiglie. In questa seconda parte della riflessione dedicata dall’autore all’attualità scolastica, emerge un quadro dove i riferimenti classici – in primis Seneca – si intrecciano con le più recenti decisioni del Ministero dell’Istruzione. Dal divieto di smartphone nelle superiori alle nuove strategie di orientamento studentesco, fino alla ridefinizione dei percorsi di scuola-lavoro e all’“anfibismo” delle nuove generazioni, sono molti i temi su cui soffermarsi.
In questo contesto, Verona diventa simbolo di sperimentazione e dialogo tra istituzioni e alunni, mentre la riflessione filosofica di Seneca torna ad essere bussola per affrontare le tensioni dell’età evolutiva in una società sempre più complessa e bifronte. Vediamo in dettaglio come queste tematiche si articolano.
Il divieto di dispositivi elettronici nelle scuole superiori: contesto e implicazioni
Una delle novità più rilevanti del 2025 riguarda il deciso intervento normativo del Ministero dell’Istruzione, che ha esteso il divieto di utilizzo di dispositivi elettronici a tutte le scuole superiori d’Italia. Questa misura è motivata dalla crescente preoccupazione per l’impatto dei dispositivi digitali, in particolare degli smartphone, sulla qualità dell’apprendimento, sulle dinamiche relazionali tra pari e sulla salute psicofisica degli studenti.
La scelta ministeriale segue il trend europeo di restrizione degli smartphone nelle scuole, ritenendo che l’uso incontrollato delle tecnologie portatili contribuisca a distrazioni continue, isolamento sociale, insicurezza relazionale e fenomeni di dipendenza. Il divieto di smartphone nelle scuole è stato accolto con reazioni diverse: alcune famiglie e docenti lo sostengono, ritenendolo necessario per ricreare un ambiente educativo più autentico, altri temono che possa confliggere con l’esigenza di formare “cittadini digitali” consapevoli.
Non meno importante è la discussione sull'inclusione digitale: in una società che si avvia rapidamente verso la digitalizzazione integrale, la sfida sta nel trovare un equilibrio tra protezione e preparazione all’uso critico delle tecnologie. Il tentativo è quello di tutelare al tempo stesso il benessere immediato e la capacità di orientarsi nel mondo futuro – una tensione che sarà al centro delle politiche scolastiche nei prossimi anni.
Il caso di Verona: un laboratorio di ascolto e confronto
Particolarmente significativo è quanto avvenuto presso un istituto superiore di Verona, dove il divieto di dispositivi elettronici è stato anticipato rispetto al dettato ministeriale. Qui, però, il “no agli smartphone” non è stato vissuto come imposizione, ma come frutto di una lunga e intensa discussione tra studenti, docenti, dirigenti e psicologi scolastici.
Il lavoro fatto a Verona può essere considerato un modello virtuoso di partecipazione: attraverso assemblee di classe, questionari anonimi, laboratori di ascolto e tavoli di confronto, si è cercato di coinvolgere i veri protagonisti della scuola nella definizione delle regole. I ragazzi hanno avuto modo di esprimere dubbi, proporre soluzioni e condividere paure legate al cambiamento. I docenti hanno ascoltato e mediato, mettendo in pratica un metodo che ricorda da vicino il pensiero dialogico dei filosofi antichi – da qui il richiamo a Seneca come figura ispiratrice di sapienza umana e capacità di prendere posizione sulle questioni morali, con mitezza ma decisione.
Dall’esperienza veronese emergono alcune buone pratiche applicabili nelle scuole di tutta Italia:
- Coinvolgimento attivo degli studenti nei processi decisionali
- Organizzazione di spazi di ascolto gestiti da esperti (psicologi, pedagogisti)
- Comunicazione chiara alle famiglie, per superare diffidenze e resistenze
- Monitoraggio degli effetti a breve e lungo termine delle nuove regole
Questo rende il caso Verona un vero e proprio laboratorio educativo, da cui deriva la consapevolezza che il cambiamento di abitudini – anche digitali – va accompagnato, spiegato, condiviso e seguito.
Generazione Z e Alpha: la sfida dell’educazione “anfibia”
Le novità introdotte dal Ministero e le esperienze come quella di Verona devono confrontarsi con le caratteristiche uniche delle nuove generazioni oggi sui banchi: la Generazione Z (i nati dal 1997 al 2012) e la Generazione Alpha (dal 2013 in poi). Questi studenti sono stati definiti “nativi digitali”, ma la nuova scommessa educativa è renderli una vera *“generazione anfibia”*, capace cioè di vivere e sviluppare relazioni sia nel mondo digitale che in quello analogico.
L’educazione anfibia è più di un semplice adattamento: richiede una didattica integrata, una formazione trasversale sulle competenze digitali e una nuova consapevolezza delle dinamiche online. Tuttavia, come emerso nelle discussioni nelle scuole, molti studenti denunciano l’incapacità di “staccare” dalle realtà virtuali, soffrendo di ansia, FOMO (fear of missing out), difficoltà di concentrazione e talvolta isolamento emotivo. I docenti e gli psicologi sono chiamati a fornire strumenti per educare a un uso equilibrato dei dispositivi, senza demonizzarli ma neppure lasciandoli del tutto liberi nel loro utilizzo.
In quest’ottica, il divieto di smartphone nelle scuole superiori può essere inserito in un più vasto progetto di educazione “anfibia”, dove l’obiettivo è aiutare gli studenti a riconoscere il valore della presenza fisica, del contatto reale e del confronto diretto, senza però rinnegare la dimensione digitale, che rappresenta una parte imprescindibile della loro identità generazionale.
Relazioni online e in presenza: costruire nuovi equilibri a scuola
Uno dei nodi centrali emersi con forza oggi riguarda il rapporto tra relazioni online e relazioni in presenza. Molte ricerche mettono in luce come la pandemia abbia accelerato processi di digitalizzazione e, di conseguenza, alterato le modalità di essere insieme tra i ragazzi. Scuole, famiglie e psicologi si ritrovano dunque a gestire nuovi equilibri relazionali:
- I legami a distanza sono spesso più “liquidi”, meno profondi e stabili;
- Le relazioni faccia-a-faccia vengono vissute a volte con disagio, imbarazzo o addirittura ansia sociale;
- La comunicazione digitale richiede nuove forme di educazione emotiva e di mediazione del conflitto.
La scuola, come ambiente di socializzazione primaria, ha il compito di colmare questa distanza e favorire la riconquista delle interazioni dirette. Iniziative come “Settimane senza smartphone”, laboratori teatrali, gruppi di dialogo e sport di squadra stanno dimostrando che gli studenti sono pronti, se accompagnati, a riappropriarsi di relazioni autentiche.
Ma la sfida principale è culturale: ristabilire la fiducia nell’incontro reale e nel tempo lento, offrendo occasioni di “disconnessione protetta” senza che ciò venga percepito come imposizione autoritaria. Qui la figura del docente – consigliere, facilitatore, mediatori di senso – assume un ruolo chiave, analogo a quello descritto da Seneca nelle Lettere a Lucilio.
Dalla PCTO alla 'Formazione scuola-lavoro': un cambiamento non solo semantico
Un altro importante cambiamento riguarda la terminologia dei percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro. Il termine PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) è stato sostituito con una dizione più chiara e immediata: “Formazione scuola-lavoro”.
Questa modifica, apparentemente solo formale, intende rendere più trasparente e comprensibile a studenti e famiglie ciò che il percorso offre realmente: un ponte concreto tra mondo scolastico e realtà professionali. L’obiettivo è quello di:
- Superare le incomprensioni e la distanza linguistica percepita tra scuola e lavoro;
- Sottolineare l’importanza crescente dell’orientamento già dai primi anni delle superiori;
- Valorizzare esperienze pratiche, stage, visite aziendali e progetti di alternanza come parte costitutiva del curriculum formativo.
Molte scuole, in particolare al Nord, hanno già iniziato a rimodulare le offerte formative, ampliando le collaborazioni con imprese locali, studi professionali e associazioni di categoria. Resta aperta la sfida della qualità: trasformare la formazione scuola-lavoro in un’esperienza davvero significativa, che aiuti gli studenti a scoprire inclinazioni, passioni e talenti in un mondo professionale in continua trasformazione.
L’urgenza di un nuovo orientamento: lotta alla fobia scolare e alle nevrosi
Uno degli effetti imprevisti del rapido mutamento delle condizioni scolastiche e sociali è l’aumento di fobia scolare, ansia da prestazione e nevrosi legate all’universo della scuola superiore. Gli specialisti segnalano da tempo una crescita significativa di casi in cui adolescenti, pur di evitare il confronto con insegnanti o compagni, sviluppano veri e propri disturbi dell’adattamento.
Il ministero ha riconosciuto come prioritaria, nel 2025, un’*azione seria di orientamento* che accompagni gli studenti nel loro percorso di crescita non solo cognitiva ma anche emotiva. Tra i punti chiave di questa nuova strategia vi sono:
- Inserimento strutturale di uno sportello di ascolto psicologico in ogni istituto superiore;
- Collaborazione tra scuole, servizi sociali e centri di salute mentale;
- Formazione specifica per i docenti su gestione del disagio adolescenziale;
- Promozione di programmi di peer support (aiuto tra pari) e mentoring;
- Percorsi di educazione all’affettività e alla cittadinanza digitale.
Affrontare il tema della fobia scolare e delle nevrosi significa riconoscere che il disagio non va mai minimizzato né medicalizzato in modo semplicistico, ma ascoltato, compreso e accompagnato con strumenti e strategie adeguate. La scuola nuova si configura così sempre più come una comunità educante a sostegno dell’intera persona, non solo dello studente.
Seneca in cattedra: la lezione ancora attuale per psicologi, studenti e docenti
In un’epoca dominata dalla tecnologia, il pensiero di Seneca offre spunti straordinari per ripensare il ruolo della scuola come luogo di formazione umana prima ancora che didattica. Nelle sue opere, Seneca pone la saggezza pratica, la serenità d’animo, il *coraggio di vivere bene*, al centro dell’educazione.
Per i docenti e gli psicologi scolastici, la lezione di Seneca è duplice: coltivare la resilienza, la capacità di governare le emozioni e di porre domande anziché dare risposte preconfezionate. Per gli studenti, “essere anfibi” significa anche sviluppare spirito critico e senso del limite, imparando a navigare tra reale e virtuale senza perdere il senso della propria umanità.
Alcuni passaggi delle Lettere a Lucilio risultano oggi profetici: “Bisogna imparare a essere amici di sé stessi prima di esserlo degli altri”, oppure “Non siamo nati solo per noi stessi”. Queste massime sono di grande stimolo anche nella cornice attuale delle scuole superiori, alle prese con problemi di identità, relazioni fluide e ricerca di senso.
La sfida del 2025 è allora quella di riscoprire la filosofia come esercizio di libertà e come strumento di benessere integrale, in dialogo incessante con la psicologia dell’età evolutiva e la pedagogia contemporanea.
Conclusioni: una scuola più umana per il 2025
Da Verona a tutta Italia, dalle aule alle famiglie, la lezione (nuova) di Seneca sembra suggerire che la vera innovazione – anche nella scuola digitale – passa sempre dalla centralità della relazione e della riflessione. Divieto di smartphone, “formazione scuola-lavoro”, orientamento contro fobie e nevrosi, educazione anfibia: tutte queste novità hanno senso soltanto se inserite dentro una visione ampia, capace di restituire all’istituzione scolastica il suo ruolo antico e sempre nuovo.
Per il 2025, la scuola italiana è chiamata a essere non solo luogo di trasmissione di saperi ma officina di costruzione di persone forti, consapevoli, capaci di stare nel mondo con coscienza critica e senso della misura. Un’eredità, questa, che dobbiamo proprio anche al pensiero di Seneca, filosofo della misura e dell’equilibrio, più attuale che mai.