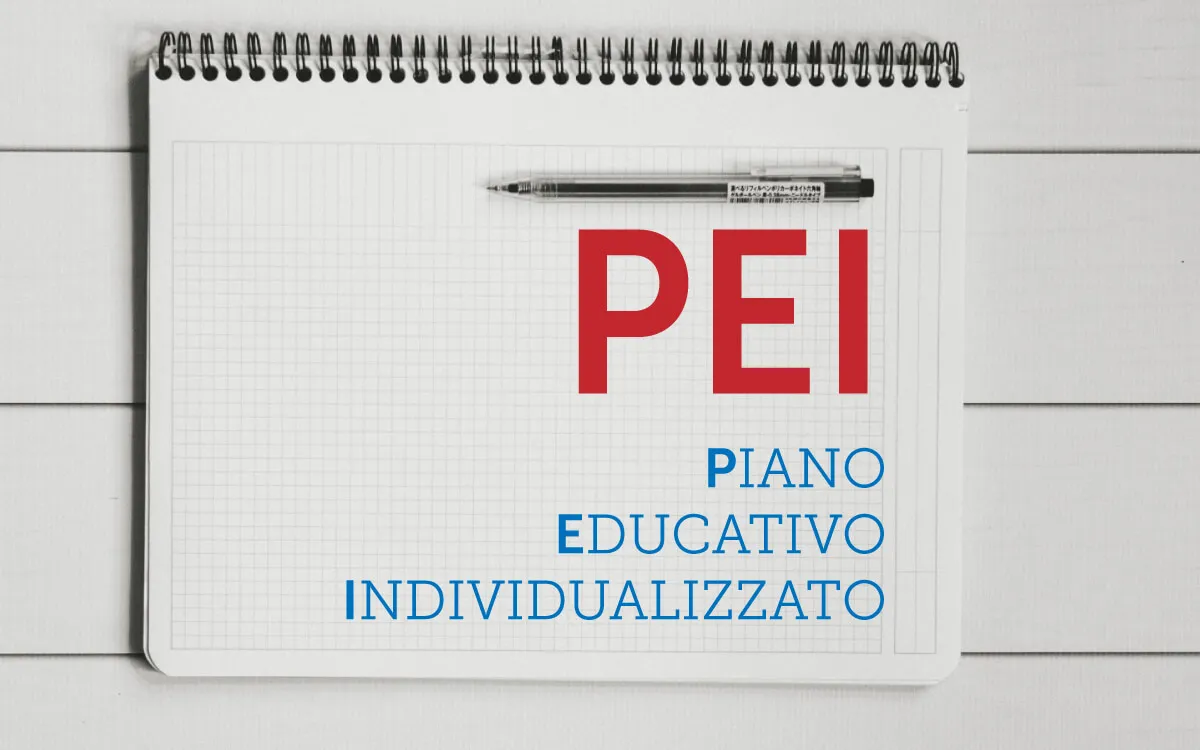Chi deve redigere il PEI? Tutto quello che i docenti devono sapere per l’inclusione scolastica efficace
Indice
- Cos’è il PEI e perché è centrale nell’inclusione scolastica
- Chi sono i soggetti coinvolti nella redazione del PEI
- Il ruolo del docente nella compilazione del PEI: obblighi, opportunità e criticità
- Le linee guida PEI scuola: dalla normativa alle prassi operative
- Il PEI e la legge 107/2015: normativa, principi e casi concreti
- Il dirigente scolastico e il coordinamento nella stesura del PEI
- Quali passaggi seguire: come compilare il PEI in modo efficace
- Esempio pratico di PEI per la scuola primaria nel 2025
- La formazione dei docenti: il corso "Guida alla compilazione del PEI 2025"
- Sintesi conclusiva: il PEI come documento condiviso per l’inclusione
Cos’è il PEI e perché è centrale nell’inclusione scolastica
Il Piano Educativo Individualizzato, noto più comunemente come PEI, rappresenta uno degli strumenti chiave per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Non si tratta di un semplice documento burocratico, ma di un progetto educativo personalizzato e condiviso, capace di guidare il percorso formativo e di integrazione sociale di ciascun studente. Il PEI inclusione scolastica è infatti la sintesi operativa della collaborazione tra scuola, famiglia e servizi sanitari, in linea con quanto previsto dalla più recente normativa italiana e dalle direttive dell’Unione Europea in materia di pari opportunità nell’istruzione.
Redigere il PEI significa elaborare una strategia educativa concreta, basata su strumenti osservativi e documentali, che risponde in modo mirato ai bisogni specifici dell’alunno. La personalizzazione e la condivisione sono dunque elementi imprescindibili: il PEI non può e non deve essere ridotto a un adempimento formale, né tantomeno delegato a un solo attore scolastico.
Chi sono i soggetti coinvolti nella redazione del PEI
Secondo le linee guida PEI scuola e la vigente normativa, la compilazione del PEI è un atto collegiale e interistituzionale. I principali attori coinvolti sono:
- I docenti curricolari: responsabili degli apprendimenti e dell’inclusione in classe
- I docenti di sostegno: figure specializzate nella didattica inclusiva e nell’adattamento dei percorsi educativi
- Il team dei docenti (nella scuola primaria) o il consiglio di classe (nella secondaria): assicurano il raccordo interdisciplinare e la coerenza pedagogica
- La famiglia dell’alunno, che partecipa attivamente alla definizione degli obiettivi e delle strategie
- Gli operatori socio-sanitari (ad es. ASL, neuropsichiatra infantile, operatori sociali): sono essenziali per una valutazione globale della situazione e per indicare eventuali terapie, ausili o interventi esterni
- Il dirigente scolastico, chiamato a garantire il coordinamento tra tutte queste figure e a vigilare sulla correttezza della procedura.
La stesura del PEI, inoltre, segue le tempistiche scandite dal calendario scolastico e si articola in precise fasi di osservazione, progettazione, verifica e revisione, a ciclo continuo. In quest’ottica, chi deve redigere il PEI? La risposta è chiara: si tratta di un lavoro di squadra, in cui ogni soggetto ha ruoli e responsabilità definite.
Il ruolo del docente nella compilazione del PEI: obblighi, opportunità e criticità
Molto spesso si sente dire che "il PEI è un compito delicato e spesso frustrante per i docenti". Effettivamente, il carico di lavoro legato alla redazione del documento PEI scuola primaria (e non solo) può essere percepito come un ulteriore onere amministrativo, soprattutto se le competenze specifiche non sono ancora ben consolidate o se manca un efficace lavoro di squadra.
Tuttavia, la compilazione del PEI rappresenta anche un’occasione preziosa per aggiornare le proprie metodologie didattiche, imparare ad osservare in modo scientifico il percorso di apprendimento dell’alunno e costruire una relazione educativa più profonda con le famiglie.
Gli obblighi dei docenti PEI si traducono in una serie di azioni concrete:
- Collaborare attivamente con il docente di sostegno e con il team multidisciplinare
- Partecipare alle riunioni e ai GLHO (Gruppi di Lavoro Handicap Operativi)
- Contribuire alla raccolta di dati e all’osservazione diretta dell’alunno
- Proporre e discutere obiettivi specifici, strategie e strumenti didattici personalizzati
- Tenere costantemente monitorata l’efficacia delle strategie messe in atto e proporre revisioni ove necessario
Il PEI non deve essere mai vissuto come "una prova di resistenza", ma come un atto di corresponsabilità educativa. In caso contrario, rischia di perdere la sua funzione inclusiva originaria, diventando solo l’ennesima carta da firmare.
Le linee guida PEI scuola: dalla normativa alle prassi operative
Il riferimento normativo fondamentale per la redazione del PEI è costituito dalla Legge n. 104/1992 e, più recentemente, dalla legge 107/2015, nota come "Buona Scuola". A queste si sommano il D.lgs. 66/2017 e i relativi decreti attuativi, unitamente alle linee guida PEI scuola emanate annualmente dal Ministero dell’Istruzione.
Le linee guida – che rappresentano un punto fermo per tutte le istituzioni scolastiche – precisano sia le strutture minime che i contenuti obbligatori del PEI. Nel dettaglio, queste vedono:
- L’analisi del funzionamento globale dell’alunno (osservazione multidimensionale)
- La definizione degli obiettivi a breve, medio e lungo termine
- La descrizione degli interventi didattici, educativi e riabilitativi previsti
- La scelta di strumenti e strategie di valutazione
- La pianificazione di attività specifiche per lo sviluppo delle autonomie personali e sociali
L’uso di modelli standardizzati, oggi diffusi in tutte le regioni italiane, ha contribuito a rendere la compilazione del PEI più agevole e trasparente, favorendo la costruzione di pratiche condivise e ben documentate.
Il PEI e la legge 107/2015: normativa, principi e casi concreti
La legge 107/2015 ha avuto l’indubbio merito di rilanciare il tema dell’inclusione scolastica, richiedendo un cambio di prospettiva: dalla semplice integrazione dell’alunno "fragile", si passa a una logica di inclusione di sistema, in cui ogni componente della comunità educante è chiamata a svolgere un ruolo attivo. Per quanto riguarda il PEI legge 107/2015, essa stabilisce che:
- Il PEI abbia una valenza centrale nel progetto personalizzato di ciascun alunno con disabilità
- Tutti i docenti e l’intero consiglio di classe/dei docenti siano direttamente responsabili della sua redazione, implementazione e monitoraggio
- Venga rafforzata la collaborazione con la famiglia e con gli enti territoriali (ASL, servizi sociali, ecc.)
- Sia favorito l’accesso a risorse, corsi di formazione e strumenti digitali per supportare l’inclusione
Nei casi concreti, tuttavia, emergono ancora molte difficoltà. Spesso la mancanza di tempo, la carenza di risorse o una non ottimale comunicazione tra scuola e servizi esterni rallentano la stesura di un PEI esempio 2025 realmente efficace. Per questo motivo, la formazione in servizio e le buone pratiche rappresentano una risorsa imprescindibile.
Il dirigente scolastico e il coordinamento nella stesura del PEI
Uno degli attori spesso sottovalutati, ma di importanza decisiva, è il dirigente scolastico PEI. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il dirigente ha il compito di:
- Nominare il referente per l’inclusione e il responsabile della compilazione del PEI
- Garantire che le procedure vengano rispettate nei tempi e nelle modalità previste
- Favorire il dialogo e il confronto tra docenti, famiglia e enti esterni
- Supportare i docenti nella partecipazione a corsi di aggiornamento (come il corso compilazione PEI)
- Predisporre tutte le risorse materiali e organizzative necessarie, come stanze per incontri, accesso a software, ore di compresenza, ecc.
La presenza attiva del dirigente assicura che il PEI non sia un atto isolato, bensì il frutto di una reale progettazione integrata. La sua mediazione può inoltre prevenire conflitti tra le parti, garantendo che l’interesse primario resti sempre il benessere dell’alunno.
Quali passaggi seguire: come compilare il PEI in modo efficace
Alla luce delle recenti riforme, come compilare il PEI in modo realmente inclusivo? Le migliori prassi operative possono essere schematizzate in alcune fasi fondamentali:
- Osservazione multidimensionale dell’alunno: occorre raccogliere dati non solo sugli apprendimenti, ma anche sulle autonomie personali, sulle relazioni e sulle potenzialità
- Coinvolgimento attivo della famiglia e, ove possibile, della stessa studentessa o studente
- Redazione collegiale delle sezioni del PEI, con distribuzione chiara dei compiti tra i docenti
- Condivisione con operatori esterni: inserire elementi provenienti dalle relazioni sanitarie, terapeutiche o educative
- Stesura degli obiettivi specifici (didattici, sociali, comportamentali, ecc.) individuando indicatori di verifica chiari
- Definizione delle strategie metodologiche: dalla personalizzazione degli strumenti compensativi/dispensativi fino alle modalità alternative di verifica
- Monitoraggio e revisione periodica: valutare costantemente l’efficacia del PEI e apportare modifiche in itinere
L’adozione di piattaforme digitali semplifica oggi gran parte della procedura. Tuttavia, il fattore umano – ovvero la reale capacità di ascolto e collaborazione – resta centrale per il successo dell’inclusione.
Esempio pratico di PEI per la scuola primaria nel 2025
Per offrire una guida più concreta, presentiamo un PEI esempio 2025 pensato per la scuola primaria.
Profilo dell’alunno
- Età: 8 anni, classe terza
- Diagnosi: Disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)
Osservazione
- Punti di forza: buone capacità logico-matematiche, spiccata creatività
- Fatica nella lettura e scrittura
Obiettivi operativi
- Migliorare la lettura fluente con software dedicati
- Potenziare la scrittura tramite esercizi guidati
- Incentivare la partecipazione attiva alle attività di gruppo
Strategie didattiche
- Uso di tabelle visive e mappe concettuali
- Compiti strutturati a difficoltà crescente
- Verifiche scritte sostituite da prove orali
Monitoraggio
- Due verifiche mensili condivise tra docente curricolare e sostegno
- Aggiornamento del PEI ogni trimestre in presenza della famiglia
Questo esempio testimonia come, attraverso una pianificazione dettagliata e condivisa, il PEI possa realmente accompagnare la crescita dell’alunno, favorendo l’autonomia e facendo sentire ogni studente parte integrante della comunità scolastica.
La formazione dei docenti: il corso "Guida alla compilazione del PEI 2025"
Nell’ottica di una scuola sempre più inclusiva, cresce l’importanza dell’aggiornamento professionale. A partire dal 12 settembre sarà disponibile, ad esempio, il nuovo corso "Guida alla compilazione del PEI 2025", rivolto a tutti i docenti e dirigenti che desiderano approfondire metodi, software e casi pratici legati alla stesura di un PEI aggiornato secondo le ultime disposizioni normative.
Il corso offre:
- Moduli teorici e pratici sulle fonti normative (da Legge 104 a L. 107/2015)
- Esercitazioni guidate su casi reali di PEI scuola primaria e secondaria
- Analisi degli errori più frequenti nella compilazione del PEI
- Strumenti digitali per l’osservazione e la valutazione dell’alunno
- Spazi di confronto con esperti e colleghi da tutta Italia
Formazione continua e confronto professionale sono ingredienti indispensabili affinché il PEI sia percepito non più come una "fatica solitaria", ma come l’occasione di crescita per tutta la comunità scolastica.
Sintesi conclusiva: il PEI come documento condiviso per l’inclusione
Redigere un PEI inclusione scolastica efficace non è un atto individuale ma un processo condiviso, che deve vedere protagonisti docenti, famiglia, servizi esterni e dirigenza. Soltanto così il Piano Educativo Individualizzato potrà davvero rispondere alle esigenze dell’alunno e divenire lo strumento principe per una scuola capace di valorizzare ogni differenza.
Affrontare con consapevolezza i compiti, le responsabilità e le opportunità offerte dal PEI (come chiarito nelle linee guida PEI scuola e nella legge 107/2015) rappresenta il primo passo verso una vera cultura dell’inclusione: passare dal "compilare una pratica" al costruire un percorso di crescita per ciascun studente.
Oggi, con il supporto di corsi come la "Guida alla compilazione del PEI 2025", esempi pratici e strumenti aggiornati, ogni scuola può fare la differenza. Un PEI ben fatto non è soltanto un dovere di legge, ma un diritto fondamentale di ogni bambino: quello di essere accolto, riconosciuto e accompagnato nella propria unicità.