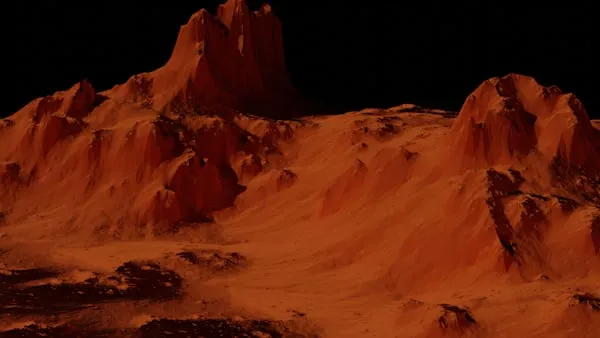Patriarcato e primati: uno stereotipo da sfatare
L’idea che il patriarcato sia una diretta eredità biologica degli umani, trasmessa dalla lunga storia evolutiva condivisa con i primati, è stata messa in discussione da uno studio recente condotto dagli scienziati dell’Università di Montpellier e dell’Istituto Max Planck. Pubblicato nel luglio 2025, questo lavoro riapre il dibattito su quali siano le effettive radici della dominanza maschile nella nostra specie e quanto, in realtà, questa rappresenti un’esclusività evolutiva oppure un mito da decostruire. Analizzando i dati su vasta scala di oltre 250 popolazioni di primati, i ricercatori offrono una visione molto più sfumata del rapporto tra sesso, potere e gerarchia nel regno animale, portando anche a importanti riflessioni sulla società umana.
Indice
- Introduzione: il patriarcato alla lente della scienza
- Il contesto evolutivo: miti e certezze
- La ricerca: metodologia e dati analizzati
- Aggressioni e dinamiche tra i sessi nei primati
- Dominanza maschile e femminile: i numeri dello studio
- L’eccezione umana e la costruzione culturale del patriarcato
- Conseguenze sui modelli culturali e sociali
- Oltre il mito: prospettive per la ricerca sociale
- Sintesi e considerazioni finali
Introduzione: il patriarcato alla lente della scienza
L’associazione tra patriarcato e natura umana sembra, a un primo sguardo, quasi indissolubile: la letteratura, la politica, le religioni, e la stessa narrazione accademica hanno a lungo sostenuto l’idea di una superiorità maschile originata da una presunta universale dominanza dei maschi sugli altri primati. Tuttavia, la scienza, come spesso accade, invita alla prudenza e alla verifica. Negli ultimi anni, con una maggiore attenzione per la ricerca interdisciplinare, si è cercato di capire quanto le strutture sociali osservate negli animali riflettano – o meno – quelle umane. Lo studio condotto dall’Università di Montpellier e dal Max Planck segna una tappa fondamentale in questa indagine, dimostrando che la realtà delle società animali è molto più complessa e meno «patriarcale» di quanto si credesse.
Il contesto evolutivo: miti e certezze
Per decenni, la biologia evolutiva ha considerato le società dei primati un modello per comprendere le origini dei comportamenti umani. In particolare, si è puntato il dito sulle gerarchie sociali basate sul sesso, con la supposta netta predominanza dei maschi sia nella leadership sia nell’accesso alle risorse. Questa lettura ha alimentato il mito di un patriarcato inscritto nel DNA umano. Tuttavia, tale generalizzazione è risultata spesso frutto di osservazioni su un numero limitato di specie o popolazioni. Numerosi ecologi comportamentali hanno suggerito che il quadro globale fosse più articolato, ma mancavano analisi quantitative su larga scala che potessero confermare o smentire la visione dominante.
La ricerca: metodologia e dati analizzati
Il nuovo studio, pubblicato nell’estate 2025 sulle principali riviste internazionali, si caratterizza per l’ampiezza e la profondità del campione esaminato. I ricercatori hanno analizzato 253 popolazioni di primati appartenenti a diverse specie sparse nei principali continenti. I dati sono stati raccolti nel corso di anni attraverso osservazioni dirette sul campo, analisi comportamentali, studi genetici e raccolta di testimonianze audiovisive, consentendo un approccio integrato e multidisciplinare.
Le parole chiave principali, come “patriarcato nei primati”, “studio dominanza primati” e “origine patriarcato umano”, riflettono la natura del lavoro: un’indagine sistematica per chiarire quanto sia diffusa e radicata la dominanza di un sesso sull’altro nel mondo dei primati. I parametri osservati includono comportamenti di aggressione, distribuzione del potere decisionale, accesso alle risorse e ruolo nei gruppi sociali.
Aggressioni e dinamiche tra i sessi nei primati
Uno degli aspetti analizzati dallo studio riguarda la frequenza e il tipo di aggressioni tra maschi e femmine. È emerso che, all’interno dei gruppi di primati, le aggressioni intersessuali sono, in effetti, piuttosto comuni: litigi, soprusi e manifestazioni di forza fisica fanno parte del repertorio sociale di molte specie. Tuttavia, la chiave di lettura offerta dai ricercatori sposta l’accento dalla semplice osservazione della violenza fisica alla comprensione delle sue conseguenze gerarchiche.
Le aggressioni, infatti, non portano sempre a una distribuzione del potere a favore dei maschi. In molte popolazioni, anche dopo episodi di conflitto, femmine e maschi mantengono ruoli di rilievo, partecipano alle decisioni di gruppo e talvolta condividono la leadership del branco. Questa evidenza scoraggia chi desidera tracciare un’equivalenza diretta tra forza fisica maschile e dominio sociale, suggerendo la necessità di approfondire i fattori culturali, ecologici e psicologici che regolano la vita dei primati.
Dominanza maschile e femminile: i numeri dello studio
Uno dei risultati più sorprendenti dello studio riguarda la reale incidenza della dominanza maschile nelle società dei primati. Su 151 popolazioni in cui era possibile stabilire con precisione il rapporto di potere tra i sessi, solo 25 hanno mostrato una netta dominanza maschile. Al contrario, ben 16 popolazioni sono risultate caratterizzate da una forte dominanza femminile, mentre la stragrande maggioranza presenta un equilibrio o alternanza di potere.
Questi dati ribaltano la prospettiva tradizionale e mettono in luce come la diversità organizzativa nel regno dei primati sia la norma piuttosto che l’eccezione. Ad esempio, tra le specie studiate figurano bonobo, lemuri, gibboni, macachi e altri, alcuni dei quali noti per strutture sociali matriarcali o per comunità in cui il comando è condiviso. I bonobo, in particolare, rappresentano un caso emblematico: le femmine giocano un ruolo determinante nelle dinamiche sociali, coordinano alleanze e influenzano le scelte collettive.
La presenza di società a dominanza femminile nei primati, storicamente considerata una rarità, trova così piena conferma e invita a una revisione dei modelli interpretativi. Questi dati suggeriscono che il cosiddetto «patriarcato evolutivo» è tutt’altro che universale, e che la varietà delle risposte adattative ha portato a esiti molto diversi anche tra gruppi affini dal punto di vista genetico.
L’eccezione umana e la costruzione culturale del patriarcato
Se il patriarcato non appare universale tra i primati, cosa spiega allora la sua diffusione tra gli umani? Gli autori dello studio, pur mantenendo un approccio cauto, suggeriscono che le radici della dominanza maschile vanno maggiormente ricercate nella dimensione culturale e simbolica delle società umane piuttosto che in una semplice eredità biologica.
A differenza degli altri primati, la nostra specie ha sviluppato linguaggio complesso, religioni strutturate, ruoli sociali codificati e sistemi politici che, sovente, hanno attribuito un vantaggio sistemico agli uomini. La storia delle civiltà mostra che il patriarcato si è evoluto e adattato a seconda dei contesti geografici, delle risorse e dei modelli produttivi, assumendo forme più o meno rigide nel corso dei secoli. La dimensione simbolica, espressa in miti, rituali e leggi, ha rinforzato disuguaglianze che nelle società animali non appaiono affatto scontate.
Questo spostamento dell’attenzione dalla biologia alla cultura apre prospettive nuove non solo per la ricerca accademica, ma anche per il dibattito sociale e politico contemporaneo. Le parole chiave “origine patriarcato umano” e “mito patriarcato evolutivo” diventano così strumenti analitici per interrogarsi sulla natura delle nostre istituzioni e sulle possibilità di un loro superamento.
Conseguenze sui modelli culturali e sociali
La ricaduta sulle discussioni culturali e politiche del nostro tempo è, inevitabilmente, di grande portata. Da sempre, teorie sull’«innata» superiorità maschile sono state utilizzate per giustificare discriminazioni e limitazione dei diritti delle donne. Se la scienza mostra che questa superiorità non è né universale né predestinata a livello evolutivo, viene meno un pilastro importante delle giustificazioni tradizionali della disuguaglianza.
Per la scuola, per la divulgazione scientifica e per chi opera nel settore dell’educazione, questa scoperta rappresenta un invito all’aggiornamento di manuali, programmazioni e politiche. I risultati dello studio dell’Università di Montpellier e del Max Planck portano a riconsiderare come presentiamo la natura ai più giovani e come costruiamo le narrazioni sulle origini dell’umanità. Mettere in discussione l’idea che il patriarcato sia ‘naturale’ significa offrire alle nuove generazioni uno sguardo più critico, inclusivo e aperto sulle possibilità di cambiamento sociale.
Oltre il mito: prospettive per la ricerca sociale
Lo studio appena pubblicato è, allo stesso tempo, una tappa importante e un punto di partenza. Gli autori sottolineano la necessità di indagini ulteriori su popolazioni di primati finora poco studiate e auspicano una collaborazione sempre più stretta tra biologi, antropologi, sociologi e storici. Soltanto attraverso un approccio integrato sarà possibile distinguere ciò che appartiene all’adattamento biologico da quanto invece deriva dall’invenzione umana.
È inoltre fondamentale continuare a interrogarsi su come le strutture di potere influenzino la società umana oltre ciò che è osservabile tra i nostri parenti più prossimi. L’introduzione di nuove tecnologie, i cambiamenti climatici, la globalizzazione e i movimenti per i diritti civili stanno già ridisegnando la mappa dei rapporti tra i sessi, sfidando i vecchi assetti e aprendo spazi per nuovi equilibri.
Sintesi e considerazioni finali
La ricerca condotta dall’Università di Montpellier e dall’Istituto Max Planck segna una svolta significativa nella comprensione delle origini del patriarcato. I dati raccolti su 253 popolazioni di primati smentiscono la narrazione di una dominanza maschile universale e inducono alla prudenza ogni volta che si voglia giustificare la disuguaglianza tra i sessi sulla base di «leggi naturali». Solo 25 popolazioni mostrano una vera e propria supremazia maschile, contro 16 in cui è invece la femmina a comandare e una maggioranza dove vige un equilibrio.
Il mito del patriarcato evolutivo appare oggi più che mai fragile. La varietà delle forme organizzative tra i primati, unite alla peculiare evoluzione culturale dell’umanità, suggerisce che il patriarcato non sia un’eredità ineludibile, ma una costruzione storica, modificabile e perfettibile. L’articolo invita, infine, a proseguire sulla strada della ricerca scientifica, della riflessione critica e dell’educazione come strumenti fondamentali per superare vecchi pregiudizi e per costruire società più eque.
In conclusione, la domanda sull’origine del patriarcato deve oggi essere posta diversamente: più che chiederci “da dove viene”, dovremmo domandarci “come possiamo trasformarlo”, smontando vecchi stereotipi e ricercando nuove forme di convivenza e rispetto tra i sessi, sia a scuola, sia nella società nel suo insieme.