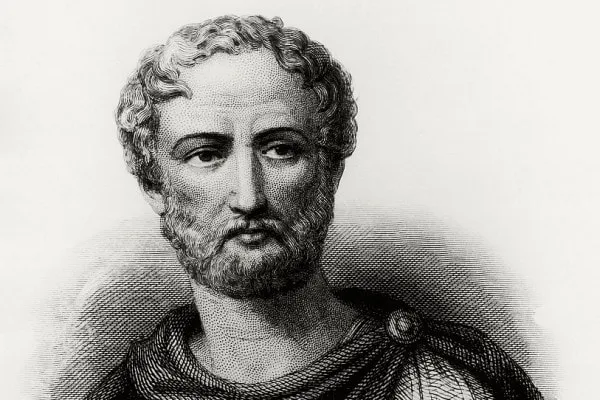Raccontare la storia attraverso i secoli: da Plinio il Giovane ai TikToker, la narrazione si evolve (ma resta centrale)
Indice dei contenuti
- Introduzione: la narrazione come filo rosso della storia umana
- Plinio il Giovane e le radici della narrazione storica
- Evoluzione della comunicazione: dalla carta ai social
- Narrazione storica nell’era digitale: TikTok e nuove forme di racconto
- Il cellulare a scuola: strumento, barriera o occasione?
- Il ruolo del docente: tra tradizione, innovazione e prestigio
- La voce delle istituzioni: Valditara e il messaggio di Leone XIV
- Prestigio, passione e crisi: il mestiere dell’insegnante oggi
- Opportunità e rischi dell’evoluzione comunicativa
- Sintesi e prospettive: come raccontare la storia oggi
Introduzione: la narrazione come filo rosso della storia umana
Raccontare la storia significa costruire un ponte tra il passato e il futuro, plasmando la memoria collettiva di intere generazioni. Dai primi scrolli della penna fino ai videoclip di pochi secondi, la narrazione storica si è costantemente rinnovata, senza mai perdere la sua funzione centrale nella formazione individuale e sociale. In questa lunga traiettoria che va da Plinio il Giovane ai moderni TikToker, emerge un interrogativo fondamentale: come cambia il modo di raccontare la storia? Quali sono le costanti e quali le rivoluzioni?
La digitalizzazione ha reso la storia più accessibile, ma anche più frammentata. Allo stesso tempo, il contesto scolastico, luogo privilegiato per coltivare spirito critico e identità culturale, si trova al centro di un acceso dibattito sull’uso del cellulare a scuola e sulla tenuta del prestigio degli insegnanti. In questa panoramica, la voce delle istituzioni si alterna a quella degli studenti e dei docenti, restituendo un quadro complesso e, per certi versi, inedito.
Plinio il Giovane e le radici della narrazione storica
La nostra idea di storia come racconto prende corpo, in Occidente, fin dall’epoca romana. Tra i principali interpreti della narrazione storica antica troviamo Plinio il Giovane, noto soprattutto per le sue Lettere. Questi testi non sono solo testimonianze epistolari, ma racconti vividi delle ansie, delle attese e delle vicissitudini dell’epoca, osservate con uno sguardo critico e personale.
Plinio coglieva la potenza della narrazione: raccontare non era solo trasmettere fatti, ma dotare di senso gli eventi. Tramite le sue parole, i posteri hanno potuto farsi un’idea non solo di ciò che accadde, ma anche di come quegli eventi venissero vissuti e percepiti. Plinio il Giovane stabilisce così uno dei capisaldi del rapporto tra scrittura e storia: la prospettiva individuale fa la differenza tanto quanto l’aderenza ai fatti.
Evoluzione della comunicazione: dalla carta ai social
Nei secoli successivi, la narrazione storica cambia supporti, modalità di diffusione e finalità. Dal manoscritto illuminato si passa alla stampa, che democratizza la conoscenza e trasforma la storia in esperienza collettiva. Nel XX secolo, la radio, la televisione e la scuola pubblica universalizzano ulteriormente il racconto della storia, rendendolo accessibile a una platea sempre più vasta.
Oggi la vera rivoluzione è il passaggio dal supporto fisico al virtuale. I social network come TikTok, Instagram, YouTube offrono strumenti di narrazione rapida, accessibile e potenzialmente virale. Ma questa trasformazione non è solo tecnologica. È culturale. Da una parte, aumenta la partecipazione e l’interazione (chiunque può essere narratore), dall’altra si impongono nuove sfide: l’attenzione ridotta, la frammentazione delle informazioni, la velocità del cambiamento.
Questo nuovo scenario impone una riflessione seria sull’evoluzione della comunicazione sociale e su come veicolare al meglio conoscenza e memoria storica alle nuove generazioni.
Narrazione storica nell’era digitale: TikTok e nuove forme di racconto
Il fenomeno dei TikToker che raccontano la storia è significativo e in crescita. Attraverso clip di pochi secondi, sfide virali e format accattivanti, la narrazione storica si rinnova e raggiunge un pubblico spesso distaccato dai mezzi tradizionali. I vantaggi sono evidenti:
- Rapidità di accesso a contenuti storici di ampio respiro;
- Coinvolgimento emotivo ed esperienziale, spesso con toni più ironici o narrativi;
- Possibilità di riattualizzare figure e eventi storici ostici o misconosciuti.
Tuttavia, i rischi sono altrettanto tangibili:
- Superficialità nell’approfondimento;
- Possibili errori o semplificazioni eccessive;
- Perdita della trasversalità e del contesto.
L’evoluzione comunicazione impone quindi una sfida educativa. Come conciliare la rapidità e l’impatto dei social con la profondità della narrazione storica? È davvero possibile raccontare con efficacia una vicenda complessa in pochi secondi?
Il cellulare a scuola: strumento, barriera o occasione?
Secondo recenti indagini, un alunno su due continua a usare il cellulare a scuola nonostante il divieto. Una cifra che non sorprende, se si considera il radicamento ormai strutturale degli smartphone nella vita quotidiana di bambini e adolescenti. Il dibattito su uso cellulare scuola è quanto mai attuale e divisivo.
Gli argomenti contrari all’uso dei cellulari sono tangibili:
- Distrazione in classe e calo della concentrazione;
- Possibile diffusione di fake news o contenuti fuorvianti;
- Difficoltà nel mantenere un clima educativo sereno e costruttivo.
Eppure, digitalizzare la didattica senza strumenti digitali sembra paradossale. Molti docenti hanno iniziato a integrare consapevolmente smartphone e social nella propria attività, ponendo limiti chiari e stimolando l’uso critico dei nuovi media. Ad esempio:
- Progetti di raccontare la storia oggi tramite video e podcast realizzati dai ragazzi;
- Analisi delle fonti e delle narrazioni digitali all’interno dei percorsi disciplinari;
- Lavori di gruppo che prevedono la produzione di contenuti multimediali.
Occorre però distinguer tra uso didattico e improprio del cellulare. Come ricordato dal ministro Valditara, *non basta saper tradurre un testo per essere maturi*: la vera maturità didattica sta nell'acquisire un giudizio critico e competente, incluso sull’uso dei media contemporanei.
Il ruolo del docente: tra tradizione, innovazione e prestigio
La scuola resta il luogo in cui la narrazione storica si incontra, si discute e si rinnova. L’insegnante svolge ancora oggi un ruolo centrale nella trasmissione della memoria e nella costruzione del senso storico.
Ma come cambia la figura del docente di fronte alle nuove sfide?
- Deve aggiornare costantemente linguaggio e strumenti;
- Affronta il calo del prestigio insegnanti nella società contemporanea;
- Si trova a mediare fra la profondità dell’insegnamento tradizionale e la velocità dei social.
Un’indagine recente evidenzia come l’88% dei docenti rifarebbe lo stesso lavoro nonostante il prestigio in calo. Questo dato dimostra quanto la passione educativa sia un valore ancora vivo, capace di resistere alle difficoltà e ai cambiamenti.
La voce delle istituzioni: Valditara e il messaggio di Leone XIV
Nel 2025, le istituzioni hanno rilanciato il dibattito sulla narrazione storica e sulla comunicazione sociale. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha rimarcato come oggi “*non sia sufficiente tradurre un testo per essere maturi*”. Serve ben altro: spirito critico, capacità di argomentazione, padronanza dei nuovi linguaggi. È una posizione che invita la scuola a mettersi in gioco, a reinventarsi continuamente.
Allo stesso modo, Leone XIV ha inviato un messaggio per la Giornata delle comunicazioni sociali, nel quale ha sottolineato il valore della comunicazione etica e della responsabilità della narrazione, specie nei contesti educativi e digitali. Ruolo fondamentale, dunque, al modo in cui i fatti vengono veicolati e contestualizzati.
Questi interventi rimarcano la necessità di bilanciare innovazione e tradizione, superando forzature ideologiche.
Prestigio, passione e crisi: il mestiere dell’insegnante oggi
Lo scenario attuale impone una riflessione profonda sul significato stesso dell’insegnare storia. Oggi i docenti italiani affrontano:
- Disillusione sociale legata alla riduzione del prestigio;
- Sistemi di valutazione sempre più complessi;
- Richiesta di competenze trasversali e digitali;
- Crescente bisogno di alleanze educative con le famiglie e le istituzioni.
Eppure, la passione per l’insegnamento continua a essere una cifra distintiva. Nonostante il quadro incerto, la maggior parte dei docenti italiani si dice ancora entusiasta e motivata. L’insegnamento resta, quindi, uno spazio privilegiato per rinnovare le forme di raccontare la storia oggi, perfino attraverso strumenti nuovi come i social media o la didattica ibrida.
Opportunità e rischi dell’evoluzione comunicativa
La evoluzione comunicazione può essere occasione o barriera, a seconda del modo in cui viene integrata nel processo educativo. Le opportunità sono numerose:
- Possibilità di stimolare interesse e partecipazione tra studenti spesso disinteressati;
- Favorire lo sviluppo di nuove competenze (digitale, problem solving, public speaking);
- Creazione di contenuti multimediali utili anche fuori dall’ambito scolastico;
- Promozione della coscienza critica nei riguardi delle fonti.
Restano però aperti rischi significativi:
- Appiattimento della narrazione storica su motivi virali o semplificati;
- Riduzione della profondità e dell’analisi critica;
- Manipolazione delle informazioni tramite strumenti digitali.
Occorre una strategia sistemica che coinvolga docenti, famiglie, studenti e istituzioni. La formazione dei docenti sulle nuove forme di narrazione, una governance chiara sull’uso del digitale e una cultura diffusa della responsabilità nella comunicazione sociale sono elementi imprescindibili.
Sintesi e prospettive: come raccontare la storia oggi
Alla luce di quanto emerso, emerge con chiarezza una doppia esigenza:
- Presidiare la profondità: La storia non può ridursi a un breve video o a un post. Richiede contesto, confronto tra fonti, capacità di argomentare.
- Aprirsi all’innovazione: La narrazione storica deve saper sfruttare le potenzialità dei nuovi media, senza perderne il senso critico.
Scuola, società e famiglia devono trovare nuove alleanze, per gestire l’uso cellulare scuola e per promuovere un dialogo costruttivo tra narrazione tradizionale e digitale. Solo così si potrà trasformare la crisi del racconto in una straordinaria occasione di crescita collettiva.
Il lavoro svolto da Plinio il Giovane nell’antichità e quello, seppur diverso, dei TikToker contemporanei, mostra che la vera costante è la necessità di dare voce ai fatti, di trasmettere significati, di educare al senso e al confronto. Raccontare la storia oggi significa tradurre in linguaggi nuovi una passione antica, affidandosi a insegnanti motivati, studenti curiosi e strumenti all’altezza delle sfide del presente.